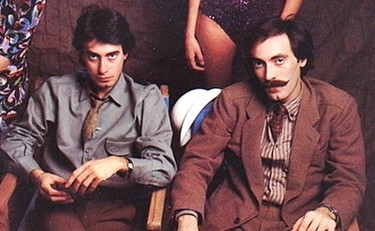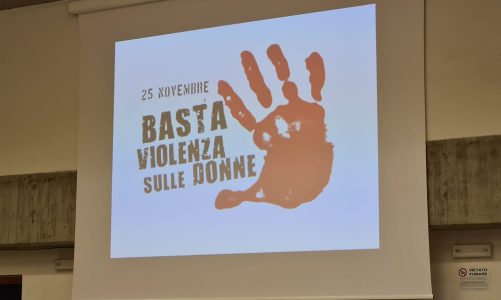Conoscere tutto ciò che spesso ci limitiamo solo a osservare o a esperire in superficie può svelarci novità sensazionali in grado di migliorare la qualità della vita. Per esempio, quante volte abbiamo affidato un desiderio a una stella cadente? O quante volte abbiamo dato sfogo alle emozioni stando con il naso all’insù per cogliere la breve scia luminosa?
Ma le stelle possono cadere? Per fortuna, questo non avviene. Le stelle sono infatti concentrati enormi di gas altamente surriscaldati, distanti solitamente miliardi di chilometri tra loro, e al cui interno si innescano continuamente processi di fusione nucleare che rilasciano quantità impressionanti di energia, soprattutto sottoforma di radiazione elettromagnetica (luce), e hanno una forza di attrazione (gravità) inimmaginabile.
Cosa sono allora quelle che chiamiamo ‘stelle cadenti’? E perché le vediamo in agosto?
Molto semplicemente, quelle scie luminose che attraversano il cielo intorno al dieci agosto non sono per niente stelle bensì piccoli frammenti di materiale solido che provengono, in questo caso, da una cometa, la Swift-Tuttle (dal nome degli scienziati che la scoprirono nell’800). Le comete sono corpi celesti composti da gas ghiacciati e rocce. Quando passano vicino al Sole il calore le riscalda e fa evaporare il ghiaccio, formando così una coda luminosa accesa. La Swift-Tuttle è una di quelle comete che passano periodicamente vicino al Sole, ogni 133 anni. La prossima volta sarà fra 105 anni, nel mese di luglio del 2126. Le stelle cadenti non sono altro dunque che i detriti provenienti da questa cometa, che rimangono sospesi nello spazio. Fu Giovanni Schiaparelli a scoprire che questi frammenti erano pezzi della Swift-Tuttle. Quando nel mese di agosto la Terra, durante il suo movimento di rivoluzione (il giro cioè che il nostro pianeta, come gli altri, compie intorno al Sole), passa in un determinato punto dello spazio interplanetario incontra questi frammenti, i quali, non appena entrano nell’atmosfera terrestre, si riscaldano e vengono distrutti dal contatto con i gas atmosferici. Questi frammenti, piccole meteore, bruciano dunque e incendiano con passaggi fulminei il cielo notturno. Ecco perché il loro passaggio (che la tradizione ha poi legato al martirio di San Lorenzo, la cui ricorrenza è appunto il dieci agosto) avviene proprio in questo periodo estivo. Il nome di questi detriti è invece Perseidi, proprio perché sembra che provengano dalla costellazione di Perseo.

Durante i gli anni l’umanità ha attribuito a questi detriti un valore romantico, di desiderio, speranza. Ma all’inizio non era proprio così. Anticamente, il passaggio di una cometa nel cielo significava disastro annunciato. La parola ‘disastro’ deriva infatti dal latino ‘astrum’, cioè astro, e quindi i corpi celesti, con l’aggiunta del prefisso ‘dis’. Ma oggi la scienza ha potuto svelare che il passaggio di una cometa non prevede alcun disastro futuro, e questo perché viviamo in un universo che è una grande macchina ordinata e caotica al tempo stesso. Il disastro sembra essere più frutto dell’azione umana. A questo però possiamo contrapporre la consapevolezza scientifica, e allo stesso tempo le grandi idee della speranza e della bellezza. Guardando le Perseidi che infiammano il cielo possiamo ancora credere che ci sia spazio per i grandi desideri.
A proposito, lo sciame di stelle cadenti sarà più intenso domani sera.